




Le
competenze in Storia
Prima delle competenze le finalità
Quale ruolo hanno le finalità nella definizione delle competenze in una disciplina come la storia che costituisce lo sguardo verso il futuro?
Due anime collaborano alla costruzione delle competenze in storia: una
è la “scienza” dello studio della natura della disciplina,
dei suoi nuclei fondanti, concetti, e contenuti da “trattare”
quando la storia è disciplina scolastica; l’altra è
l’“arte” della selezione dei fini e degli scopi di tale
insegnamento. La prima compete essenzialmente agli esperti, la seconda
ai docenti. Ad essi è infatti chiesto di fare dei ragionamenti
sulle finalità. Essi sono i veri progettisti della formazione che
comporta una visione sul senso dell’intervento educativo.
Nelle indicazioni ministeriali in genere le finalità compaiono,
è vero, ma esse risultano poi sganciate dai precetti sulle singole
discipline e, quando le cerchi negli spazi dedicati agli obiettivi, competenze
o contenuti, non sono visibili.
L’insegnante che si ritrova a dover definire le competenze in relazione
al curricolo della sua scuola attinge in prima istanza alle indicazioni
generali del curricolo di stato; secondariamente, nell’atto di descrivere
dettagliatamente le competenze (e da lì gli obiettivi i contenuti
e i metodi per raggiungerle) si accorge che non può mutuarle tout
court da repertori vari, ma le deve ritagliare su misura per il suo contesto.
Il suo contesto è il “bacino” culturale e sociale che
gli suggerisce in realtà una serie di input di tipo valoriale che
riguardano i bisogni dell’utente e delle famiglie e le intenzionalità
che la mentalità collettiva attribuisce alla scuola. Ma rispetto
a questi elementi l’insegnante è comunque un soggetto staccato
e particolare, detentore di una propria visione delle cose che sono frutto
della sua personalità soggettiva e della sua cultura. Si tratta
da parte sua di mediare tra vari bisogni e vedute, con la consapevolezza
che da questa mediazione conseguono scelte didattiche precise.
Prima quindi di lavorare sugli oggetti della “scienza” (ovvero
di combinare nuclei fondanti, concetti, metodi), disaggregandoli per dare
poi corpo alle competenze, certo decise in équipe, per i suoi alunni,
deve affrontare la riflessione sulle finalità, le quali informano
tutta la costruzione delle competenze.
A seconda di ciò che il docente pensa sulle finalità dell’insegnamento
della storia cambiano le competenze e l’aggregazione degli oggetti
fondanti.
In altre parole non è irrilevante che il docente si chieda: devo
trasmettere dei valori, quali, devo smascherare dei modelli interpretativi,
quali “rilevanze” vanno considerate, quali sono le autorità
che possono dire quali sono i contenuti essenziali?
| …ma cosa pensano i giovani sulla
storia come disciplina scolastica? |
- una materia scolastica e nulla più
- una fonte di scoperta, un’avventura che ti può interessare - una possibilità di apprendere dai fallimenti e dai successi degli altri - qualcosa di morto e passato che non ha niente a che fare con la propria vita attuale - un gran numero di esempi istruttivi - mostra le origini delle attuali condizioni di vita - una sequela di crudeltà e disastri - un modo per dirigere la propria vita Indicatori utilizzati per conoscere cosa pensano gli adolescenti sul senso della storia come disciplina scolastica, in un questionario della ricerca comparata, la Youth and History, in A comparative European Survey on Historical Consciousness and Political Attitudes among Adolescents, Hamburg, Koerber-Stiftung, 1997. In E. Lastrucci, Specificities of Historical Consciousness in Italian Adolescents, in M. Angvik, B. von Borries, v. 1, pp. 344 e segg. compare la parte relativa ai giovani italiani. |
Proviamo a fare alcune ipotesi
su come si possono combinare finalità e competenze. Per semplificare,
e al puro scopo di dimostrare quanto detto, immaginiamo di comprimere
in tre possibili varianti l’invece complessa gamma delle finalità.
Prima ipotesi: la storia è formatrice di
identità, costruisce sensi di appartenenza e giustifica
o non giustifica le organizzazioni sociali e politiche e i sistemi culturali.
È una visione della storia che ammette il valore costruttivistico
della scuola e che seleziona valori precisi che possono rispondere, con
dosaggi diversi, a esigenze ideologiche o ideali.
I contenuti che verranno selezionati sono soprattutto quelli che tradizionalmente
sono stati assunti da un certo gruppo come fondanti rispetto alla comunità
(nazione, federazione, religione). Essi mutuano dei valori. In genere
in questo ambito, visto che il presente del contesto sembra essere frutto
di processi avvenuti nel passato, la logica che li governa è quella
giustificatoria. Spesso alla base vi è anche l’idea che il
progresso sia “qui e ora”. Quanto più il presente vuole
giustificarsi con queste “pezze” del passato tanto più
la storia verrà vista come un processo deterministico e osservabile
in modo scientifico. La storia si farà su porzioni limitate e ritenute
significative, sulle quali verrà ricostruita una temporalizzazione
ad hoc.
Le competenze che ne conseguono sono:
- saper ricostruire “le rilevanze” di un processo storico
con criteri di oggettività;
- saper collegare il progresso, di cui il presente in cui si vive è
un momento alto, con un passato che lo ha preparato;
- saper leggere nell’evento storico l’inevitabilità
di un processo iscritto nell’ordine naturale o provvidenziale.
A livello metodologico le competenze sono:
- saper applicare criteri metodologici corretti;
- saper riprodurre catene storiche secondo il criterio causa-effetto;
- saper distinguere tra ciò che è fonte e ciò che
non lo è.
Seconda ipotesi: la storia è
una disciplina che si organizza secondo alcune procedure. Anche
nella scuola possiamo ripercorrere queste operazioni, tra l’altro
compatibili con “i bisogni” (anche indotti) cognitivi dell’alunno.
È una visione della disciplina che la priva dello spessore del
contenuto in quanto punta sulla costruzione dell’intelligenza e
non del senso della storia come risultato di una ricostruzione. Anche
altre discipline possono produrre gli stessi effetti. A seconda di come
viene gestita, l’analisi dei modelli storiografici può contribuire
positivamente alla costruzione del senso critico nell’alunno.
Gli ambiti di indagine sono quelli più funzionali alle operazioni
che si vogliono far compiere. I periodi scelti possono essere anche segmenti
temporali molto corti, senza problemi di
contestualizzazione.
Le competenze che conseguono a questa visione della storia sono:
- saper smontare modelli storiografici e saper manipolare variabili e
ipotesi;
- saper costruire sulla base di dati e relazioni ipotesi da mettere a
confronto con modelli storiografici;
- saper usare procedure e tecniche nelle operazioni di decodificazione
dei diversi linguaggi;
- saper attribuire il valore di testo o fonte a ogni oggetto, comprendendo
il relativismo dell’attribuzione di senso;
- saper entrare nello specifico evitando risultati generalizzanti.
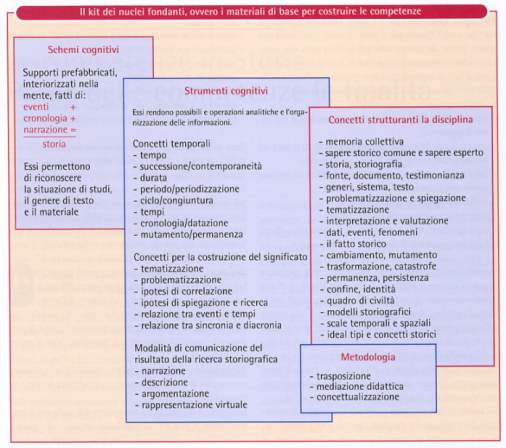
Terza ipotesi: la storia è
una ricostruzione scientifica (nel senso della quantità
e della variabilità degli elementi che mette in azione) di un fatto,
all’interno della complessità del reale di cui è possibile
fare una descrizione (o una rappresentazione), per lo più secondo
criteri multidisciplinari (cfr. con la concezione della storia come “esostoria”
di D. Parisi 2001). La realtà è osservabile ma non con gli
strumenti tradizionali (lo stesso lavoro dello storico cambia metodologicamente
e nella sostanza): il computer può permettere quelle operazioni
di simulazione della complessità del reale che possono contenere
grandi quantità di variabili e di dati, in rappresentazioni visuali
che modificano lo sguardo sull’evento. È una storia vista
dall’esterno, dal punto di vista di altre discipline. Essa rinobilita
il criterio della causalità. La parte di realtà osservabile
si fa più ampia e non ha senso la porzione o il “locale”;
il “presente” e il “complesso” sono al centro
dell’attenzione.
Questa visione non pretende peraltro l’oggettività della
ricostruzione storica in quanto dà per scontata la relatività
dei dati e la varietà dei punti di vista.
Le competenze che derivano da questa visione della storia sono in parte
innovative, in parte comuni a quelle che derivano da altre ipotesi:
- saper usare gli strumenti multimediali per gestire le rappresentazioni
della complessità, ovvero lavorare sulle varianti e sul rapporto
causa-effetto;
- saper rappresentare le trasformazioni in modo modularmente strutturato
e reticolare (in alternativa alla rappresentazione sistematica e lineare);
- saper utilizzare i linguaggi e l’operatività di discipline
diverse per ricostruire la complessità del reale;
- saper generalizzare;
- saper definire il presente con operazioni di contestualizzazione e lettura
dei segni del passato.
Questa visione può apparire una sfida utopistica
(Giusti e Somella 2001): essa suggerisce però un incoraggiamento
al relativismo dei significati che si vogliono attribuire ad un’epoca;
può sostenere con strumenti nuovi l’idea che lo studio della
storia è integrazione di rappresentazioni del passato con nuove
rappresentazioni (Manesso). A guadagnarci può essere il Dna dell’insegnante
che come un gigante che si porta sulle spalle il bambino, che dall’alto
intravede un orizzonte più ampio, incomincia a guardare nella sua
stessa direzione, il futuro.
Silvana Presa
Laureata in Filologia romanza.
Insegnante di materie letterarie nella scuola secondaria superiore.
Attualmente utilizzata presso l’Ufficio Ispettivo Tecnico dell’Assessorato
all’Istruzione e Cultura della Valle d‘Aosta nel progetto
Storia e Patrimonio culturale.
Bibliografia
Parisi D. (2001), Simulazioni, la realtà rifatta nel computer,
Il Mulino.
Parisi D. (2000), Scuol@.it, Mondadori, Milano.
Giusti F., V. Somella (2001), Povera scuola, Donzelli, Napoli.
Lastrucci E. (2000), La formazione del pensiero storico, Paravia, Torino.
Roseti P. (1992),(a cura di), in particolare il saggio di I. Mattozzi
Le parole del programma e le riconversioni dell’apparato concettuale,
pp. 13 e sg., IRRSAE Emilia Romagna.
Mattozzi I. (2000), “Dai nuclei fondanti della storia alle competenze
del sapere storico” in Dossier degli Annali Pubblica Istruzione
n.5/6.
Administration générale de l’Enseignement et de la
Recherche scientifique (1999), Compétences terminales et savoir
requis en histoire, Bruxelles.
Ministero Pubblica Istruzione (1999), Lo sguardo di Giano.
Boscolo P. ((1986), Psicologia dell’apprendimento scolastico. Gli
aspetti cognitivi, Utet, Torino.
Pinotti M. (2000), “Il curricolo verticale” in Italia contemporanea
pp. 337 e sg., ottobre.
Ministero Pubblica Istruzione (1999), Non è più la stessa
storia, (in particolare per i saggi di Mattozzi I.).
Montalgero J. (1975), “La genèse des raisonnements et des
concepts temporels” in Du temps biologique au temps psychologique,
PUF, Paris.
Fraisse P.(1967), La psychologie du temps, PUF, Paris.
