




La competenza metalinguistica come ”ponte“ tra la lingua orale e la lingua scritta
La competenza metalinguistica e la conoscenza fonologica sono considerate da molti studiosi come requisiti fondamentali per l’apprendimento della scrittura e della lettura. Alcune attività metafonologiche, possono, sotto forma di gioco, favorire lo sviluppo del processo cognitivo.
In ambito linguistico, e più precisamente nell’ambito
della pedagogia della scrittura e della lettura, si è passati da
un momento storico contraddistinto dal rilievo assegnato all’acquisizione
di adeguate competenze percettivo-motorie, considerate necessarie per
realizzare l’atto di scrittura e di lettura, al momento attuale
in cui, a partire dagli studi pionieristici di Liberman e Schankweiler
ed anche da quelli di Ferreiro e Teberosky negli anni settanta, si attribuisce
una maggior importanza agli aspetti cognitivi nel processo di acquisizione
della capacità di leggere e di scrivere. In particolare è
emerso un notevole ricorso alla fonologia, per cui numerosi studiosi
oggi concordano nel ritenere che l’analisi della parola scritta
in segmenti fonetici, cioè in unità astratte prive di significato,
rappresenti il punto critico nei momenti iniziali dell’apprendimento
della scrittura e della lettura (Monighetti, 1994).
Olson ha affermato che, all’inizio dell’avvicinamento del
bambino alla lingua scritta, si verifica un importante cambiamento
concettuale strettamente legato al modo nuovo dei bambini di orientarsi
nei confronti del linguaggio: tale orientamento è costituito dall’attenzione
prestata, più che ai contenuti, alle strutture della lingua in
quanto tali (1979). Si realizza, quindi, l’apprendimento di una
nuova competenza linguistica nella quale la forma viene distinta
dal contenuto: essa consiste nel divenire consapevoli del fatto che la
lingua è un artefatto, è composta di unità sintattiche
(suoni, parole e frasi) e di strutture semantiche (Magri, in Cardarello,
Chiantera, a cura di, 1989). Tale consapevolezza è quella che viene
definita “competenza metalinguistica”, che ritengo
possa essere considerata come un “ponte” tra lingua orale
e lingua scritta (Vignola, 2000).
A sostegno della mia definizione della “competenza metalinguistica”
come “ponte” tra la lingua orale e la lingua scritta vi sono
gli studi sul linguaggio verbale di Mattingly, Stella e Nardocci che,
come sostenuto da Gorrini, Ioghà e Brunati, hanno evidenziato la
presenza di diversi livelli di competenza, riconoscendo nelle competenze
metalinguistiche i fattori maggiormente coinvolti nell’apprendimento
della scrittura e della lettura. Soprattutto le prime osservazioni del
bambino sulla correttezza grammaticale degli enunciati verbali, o più
in generale sulla struttura del parlato, rappresentano gli indizi dello
sviluppo della competenza metalinguistica consistente nell’attenzione
prestata alla struttura del messaggio prescindendo dal suo contenuto.
Pare che questa capacità sia correlata ad un più generale
sviluppo metacognitivo, che si realizza tra i 2-3 ed i 7-8 anni e che
consiste nell’attivazione di processi di controllo necessari per
verificare la struttura dell’enunciato.
Questa competenza non si sviluppa in modo spontaneo come la lingua orale,
ma solo in conseguenza dell’esposizione del bambino a stimoli adeguati
(1999).
La competenza metalinguistica è, quindi, un processo cognitivo
e si può favorire grazie a specifici stimoli quali le scritte nell’ambiente
circostante ed in quello scolastico, gli atti di scrittura e di lettura
degli adulti in presenza del bambino, i giochi di parole, ecc., che possono
condurre i bambini a riflettere in modo spontaneo sull’universo
della letto-scrittura (termine quest’ultimo attualmente utilizzato
per indicare l’insegnamento-apprendimento della scrittura e della
lettura, considerato come un processo in cui scrivere e leggere sono strettamente
collegati).
Negli ultimi vent’anni molti studiosi (Liberman, Pontecorvo, Zucchermaglio
ed altri) hanno analizzato i rapporti tra competenza metalinguistica e
processo di apprendimento della scrittura e della lettura e sono giunti
alla conclusione che il livello di competenza metalinguistica raggiunto
dai singoli bambini all’ingresso della scuola elementare è
un indice predittivo particolarmente significativo nei confronti dei futuri
successi nell’apprendimento in ambito linguistico.
Tutto ciò sottolinea la notevole importanza della scuola dell’infanzia
e dell’ambiente circostante nello stimolare il bambino in questo
processo di avvicinamento al “mondo delle scritte” facilitando
in lui la riflessione metalinguistica.
All’interno della competenza metalinguistica, gli specialisti hanno
poi individuato un’abilità che viene indicata con termini
diversi come “coscienza fonemica”, o “consapevolezza
fonica”, o “conoscenza fonologica” ed è consensualmente
ritenuta come un insieme di abilità di natura metalinguistica.
A parte le varie disquisizioni terminologiche, un numero sempre maggiore
di studiosi ritiene che la conoscenza fonologica sia un fattore
determinante per l’apprendimento dello scrivere e del leggere (Monighetti,
1994).
Se, infatti, si tiene presente il fatto che le parole scritte devono essere
apprese dal bambino comprendendo il rapporto esistente tra la veste sonora
e quella grafica delle lettere, è necessario che i bambini orientino
il loro interesse innanzitutto alla veste sonora analizzandola: di conseguenza
è facile intuire come la capacità di effettuare una buona
analisi dei suoni della parola diventi una condizione fondamentale per
scrivere e leggere.
Questa abilità, definita “metafonologica”, viene considerata,
fra le competenze metalinguistiche, come la più attinente all’acquisizione
della scrittura e della lettura partendo dalla constatazione che, essendo
la nostra lingua scritta un sistema su base fonetica, esso richiede una
elaborazione del linguaggio parlato in modo da consentirne un confronto
con il codice scritto (Gorrini, Ioghà, Brunati, 1999).
In sintesi occorre ricordare che:
- per competenza metalinguistica si intende la capacità
di riflettere sulla struttura del linguaggio e di usarlo per spiegare
la lingua orale stessa (da meta che significa: “che va oltre, che
è al di là” e linguaggio, quindi, per metalinguaggio
si intende l’uso del linguaggio per spiegare il suo funzionamento
andando al di là della sua funzione comunicativa);
- per conoscenza fonologica si intende la capacità di
analizzare la struttura sonora della parola, cioè di considerare
separatamente i suoni che compongono ciascun termine.
Tra le varie attività metafonologiche, volte allo sviluppo della
conoscenza fonologica, si possono ricordare: il riconoscimento del suono
iniziale delle singole parole, il riconoscimento di analogie tra le lettere
iniziali di parole diverse, la suddivisione della sequenza costitutiva
delle parole in fonemi isolati, il riconoscimento e la produzione di rime,
ecc. Tali attività possono già essere svolte in forma di
gioco nella scuola dell’infanzia per poi continuare nel primo ciclo
della scuola elementare. A titolo esemplificativo vengono qui di seguito
proposte tre di queste situazioni ludiche volte allo sviluppo della conoscenza
fonologica (Poli, 1994).
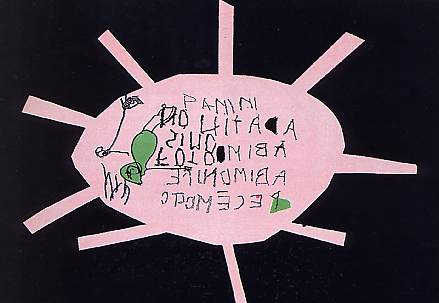
GIOCO DEL COME
Si tratta di un’attività che si può incominciare con
bambini di 4-5 anni e continuare fino ai primi mesi della classe prima
elementare. Essa ha per obiettivo lo sviluppo della conoscenza fonologica
e della capacità di riflettere sulla forma delle parole.
Per lo svolgimento di tale gioco l’insegnante prepara vari cartoncini
con immagini di oggetti familiari o di uso comune, quindi ne mostra uno
alla volta a ciascun bambino chiedendo: “Dimmi una parola che incominci
come... l’oggetto raffigurato” (se, ad esempio, sul cartoncino
è riprodotta una mela, l’insegnante chiederà: “Dimmi
una parola che incominci come mela”).
Se un bambino, di fronte alla richiesta di dire una parola che incominci
come, ad esempio, mela, risponde pera, occorre tenere presente che da
parte sua non vi è tanto una incomprensione delle modalità
di svolgimento del gioco, quanto piuttosto una difficoltà ad uscire
dal campo semantico per entrare nella struttura fonologica delle parole,
passando quindi dalla considerazione del significato a quella della forma
dei termini. In questo caso l’insegnante interverrà dicendo
al bambino che la sua risposta è sbagliata e gli riproporrà
la domanda inducendolo così a riflettere sul tipo di richiesta
che gli è stata rivolta.
E’ consigliabile svolgere questa attività singolarmente con
ogni bambino e poi successivamente in piccolo gruppo (10, al massimo 15
bambini) per favorire l’interazione tra pari, permettendo così
il verificarsi di scambi che sono molto utili alla riflessione fonologica
di ciascuno dei bimbi coinvolti nel gioco.
ARRIVA UNA NAVE CARICA DI...
E’ un gioco che si può svolgere con i bambini a partire dai
4 anni fino alla classe prima elementare.
L’obiettivo è quello di sviluppare nei piccoli la conoscenza
fonologica e la capacità di discriminare e segmentare le parole.
L’attività si svolge seduti a cerchio su un tappeto o sulle
sedie e chi conduce il gioco (all’inizio l’insegnante, poi
un bambino per volta) indossa un berretto da “capitano” costruito
con il cartoncino, la stoffa o altro materiale. Il “capitano della
nave” impartisce quindi il comando: “Arriva una nave carica
di cose che incominciano con... e poi pronuncia una sillaba (ad esempio:
PA)”.
I bimbi devono, pertanto, dire una parola che incominci con la stessa
sillaba data dal capitano (ad es.: PASTA) e colui che, per primo, trova
la parola, diventa a sua volta il comandante, indossa il cappello e il
gioco continua.
E’ meglio che all’inizio dell’attività si utilizzino
sillabe piane (es.: PA), perché, a livello fonologico, sono più
facilmente percepibili e perché si crea un fenomeno ripetitivo
(PA: PANE, PASTA,...) che facilita il processo di anticipazione. Successivamente
si passerà alle sillabe sdrucciole (es.: STRA) ed, infine, ma solo
con bambini dai 5 anni in su, alla singola lettera iniziale (“Arriva
una nave carica di cose che incominciano con... ad esempio P, M, ecc.”),
che va pronunciata senza legarvi alcun altro suono (non si dovrà,
cioè, assolutamente dire: “Arriva una nave carica di cose
che incominciano con PI oppure EMME, ecc.” perché in tal
modo si provocherebbe solo confusione nel bambino e non gli si consentirebbe
di riflettere sui singoli fonemi).
LA RUOTA DEI COLORI
Anche questo gioco si può incominciare con bambini a partire dai
4-5 anni e continuare nella classe prima elementare.
Gli obiettivi dell’attività sono lo sviluppo delle competenze
linguistiche e delle conoscenze fonologiche e lo sviluppo della capacità
di segmentare e analizzare le parole.
Per lo svolgimento del gioco è necessario costruire dapprima, con
il cartone o il compensato, una ruota girevole colorata a spicchi e montata
su un supporto dotato di indicatore di fermata e preparare, inoltre, a
parte, vari cartoncini colorati con le stesse tonalità presenti
negli spicchi della ruota.
Ad ogni bambino vengono consegnati almeno tre cartoncini colorati, quindi,
a turno, un partecipante al gioco per volta gira la ruota ed i compagni
controllano se fra i cartoncini consegnati loro c’è quello
con il colore segnalato dalla freccia di arresto. Il bambino che ha il
cartoncino dello stesso colore di quello indicato dalla freccia sulla
ruota viene invitato a dire una parola che incominci come il nome del
colore uscito: ad esempio, rosa›rotolo.
Con il progredire dell’età dei bambini e dello sviluppo delle
loro conoscenze fonologiche si possono poi inserire delle varianti al
gioco: stesso fonema iniziale, stessa sillaba finale, stessa vocale o
consonante iniziale, ecc.
Occorre precisare, infine, che le attività qui presentate, come tutti i giochi metafonologici, vanno proposti con sistematicità ai bambini durante tutto l’anno scolastico per favorire in loro lo sviluppo della competenza metalinguistica; inoltre, per permettere a tutti di partecipare ai giochi, è necessario che essi vengano proposti a gruppi di 10-15 bambini al massimo, favorendo così anche il realizzarsi dell’interazione tra pari, che è particolarmente utile al fine dello sviluppo della conoscenza fonologica in tutti i partecipanti al gioco.
Teresina Vignola
Insegnante di scuola materna nella sede di Santa Vittoria
d’Alba (CN).
Laureata in Pedagogia all’Università degli Studi di Torino.
Docente incaricata di Funzione Obiettivo con ruolo di sostegno al lavoro
dei docenti
nell’Istituto Comprensivo di Santa Vittoria d’Alba-Cinzano
(CN).
Relatrice in Corsi di Formazione-Aggiornamento sulla “Costruzione
della lingua scritta nel bambino”.
Bibliografia e sitografia
CARDARELLO R., CHIANTERA A. (a cura di), (1989), Leggere prima di
leggere. Infanzia e cultura scritta, La Nuova Italia, Firenze.
GORRINI C., IOGHA’ D., BRUNATI E., (1999), Prerequisiti cognitivi
e metalinguistici nell’accesso alla lingua scritta, in http://digilander.iol.it/dioghà/index.html.
MONIGHETTI I., (1994), La lettera e il senso. Un approccio interattivo
all’apprendimento della lettura e della scrittura, La Nuova Italia,
Firenze.
OLSON D. R., (1979), Linguaggi, media e processi cognitivi, Loescher,
Torino.
POLI L., (1994), Alletterando, Nicola Milano Editore, Bologna.
VIGNOLA T., (2000), Il percorso di costruzione della lingua scritta nel
bambino (aspetti teorici, diagnostici e didattico-operativi), tesi di
Laurea non pubblicata, Università degli Studi di Torino, Facoltà
di Scienze della Formazione.
