




Le competenze in scienze dei futuri geometri
Qualche chiave di lettura per definire alcune competenze scientifiche e favorire il loro potenziamento negli aspiranti geometri.
Le scienze sperimentali sono, da sempre, una disciplina caratterizzata
da un alto grado di complessità, attribuendo al termine complessità
non tanto il più comune significato di difficoltà, che non
sarebbe in ogni caso fuori luogo, quanto quello di molteplicità.
Le scienze, più di altre discipline, sono caratterizzate da un
insieme di saperi complesso, in quanto estremamente vasto e destinato
ad aumentare pressoché all’infinito, con velocità
esponenziale. Saperi che crescono perché spinti dall’innato
desiderio di conoscere della specie umana e la cui acquisizione è
limitata dall’inadeguatezza degli strumenti a disposizione.
Nessuna scuola, nemmeno la più specialistica è in grado
di stare al passo con questa crescita, se non trasmettendo saperi preconfezionati,
sintesi disciplinari limitate e limitanti, elenchi di nozioni di tipo
enciclopedico. È allora necessario, da un lato operare una scelta
oculata dei saperi irrinunciabili da trasmettere, dall’altro privilegiare
l’acquisizione di competenze.

Possedere una competenza può significare essere
in grado di risolvere un problema in un contesto preciso, utilizzando
le proprie abilità e le conoscenze acquisite durante il proprio
percorso formativo. Significa quindi acquisire strumenti intellettuali
e cognitivo - operativi via via più potenti, che consentono di
apprendere ed elaborare autonomamente i saperi che saranno indispensabili
per la vita e per la professione o che la società, in continua
evoluzione, impone di capire.
Basti pensare ai grandi problemi a cui tutti, scienziati e non, siamo
chiamati a dare risposta, nell’interesse del benessere, forse della
sopravvivenza, collettivi: dalla fame nel mondo, alle epidemie, alle grandi
scelte in campo energetico.
Conoscere pienamente il significato di clonazione significa comprenderne
la grande potenzialità per la cura di malattie fino ad oggi letali,
mediante l’utilizzo di cellule staminali; la più diffusa
convinzione che significhi fabbricare delle pecore Dolly, copie conformi
all’originale per ogni specie vivente, compresa quella umana, rischia
di travisarne il significato, limitandone le applicazioni.
Solo comprendendo le cause dei fenomeni che hanno originato gli eventi
alluvionali nel nostro paese negli ultimi anni, siano queste variazioni
climatiche, responsabilità umana o normale evoluzione morfogenetica
del territorio, si potrà intervenire nel modo più efficace,
o quantomeno nella effettiva direzione di contenimento del rischio.
È indispensabile quindi definire competenze, chiare e certificabili,
individuare saperi essenziali, progressivi e trasversali e infine costruire
percorsi didattici adeguati agli obiettivi conoscitivi prefissati. Le
caratteristiche delle discipline scientifiche richiedono però alcune
considerazioni di carattere generale.
Molte scienze o una scienza
La complessità delle Scienze, l’uso del plurale lo conferma,
ha determinato, in particolare nella scuola italiana, con la suddivisione
in numerosi indirizzi, ad indicare l’esistenza di “molte scienze”;
anche la Storia però è fatta da molte storie...
Due sono gli indirizzi principali, le Scienze della materia, costitute
a loro volta dalla Fisica e dalla Chimica e le Scienze della natura, costituite
dalla Biologia e dalla Scienza della Terra e dello Spazio.
Le discipline scientifiche sono separate per ragioni di studio e di analisi,
in coerenza con le attuali competenze dei docenti e con i corsi di laurea
specifici.
Si tratta in effetti di un artificio didattico, perché esiste una
sostanziale unitarietà tra tutte le scienze.
I confini tra le discipline sono sfumati ed ognuna di esse è costruita
su discipline che si interessano di complessità inferiori; all’aumentare
della difficoltà dei concetti affrontati emergono nuove acquisizioni
e nuove proprietà, ma mai in contrasto con quanto è considerato
valido per i livelli di complessità inferiore. Particolarmente
utile in termini di nuove scoperte si stanno dimostrando proprio le zone
di limite, o di sovrapposizione tra le varie discipline.
La frammentazione delle scienze può essere responsabile del ruolo
secondario, della sottostima culturale e formativa che le caratterizza,
in particolare nella Scuola italiana di chiaro stampo umanistico. Eppure
i saperi scientifici sono indiscutibilmente generativi di conoscenze,
perché creano motivazione e stimoli per la ricerca; sono formativi
perché forniscono i mezzi per comprendere i grandi fenomeni, gli
eventi, naturali o indotti dall’uomo; sono generativi di competenze
perché forniscono strumenti di elaborazione e di gestione delle
conoscenze. L’unitarietà delle scienze interessa evidentemente
gli oggetti di studio, che appartengono tutti al mondo fisico e naturale,
ma principalmente i metodi di approccio disciplinare, quindi il “metodo
scientifico sperimentale”, i percorsi che permettono di perseguirlo
e le competenze ad esso correlate.
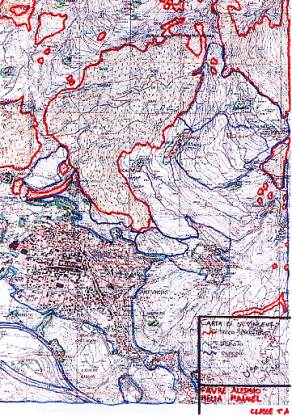
Quali competenze
Gli approcci disciplinari e le competenze che questi richiedono sono diversi:
la chimica e la fisica sono discipline che privilegiano e sviluppano competenze
di analisi, mentre la biologia e la scienza della terra comportano principalmente
competenze di sintesi. In tutta l’area disciplinare scientifica
è pratica comune l’utilizzo di metodi e tecniche diversificate,
che coniugano approcci e percorsi diversi, che utilizzano separazioni
e ricomposizioni, rapidi passaggi dal micro al macro, dal vicino al lontano,
nel tempo e nello spazio, strumenti efficaci, se non indispensabili anche
per vincere disinteresse e demotivazione.
In realtà però esistono competenze ricorrenti che ritornano
in tempi diversi, ovviamente con livelli adeguati all’età
evolutiva degli studenti, sia all’interno della singola disciplina
sia all’interno dell’ambito corrispondente.
La competenza, “porsi problemi e formulare ipotesi per la soluzione
dei problemi prospettati” è base del metodo scientifico sperimentale
di galileiana memoria, sia per il ricercatore destinato a grandi scoperte,
che per lo studente che si avvicina per la prima volta alla disciplina.
Problematizzare è premessa per la ricerca, a qualunque livello
e in qualunque direzione questa si muova, ma è anche formalizzazione
del bisogno di sapere, universale, comune a tutti bambini nell’“Età
dei perché”, bisogno troppo spesso e troppo prematuramente
represso da genitori sempre impegnati e da insegnanti non sufficientemente
attenti.
Le competenze: il metodo scientifico
“Fare esperienza per trovare segni, indizi, prove utili alla formulazione
di ipotesi sullo svolgersi di un evento, e per la soluzione di problemi
semplici” ... “sviluppare atteggiamenti di curiosità,
attenzione rispetto alla realtà naturale, di interesse per l’indagine
scientifica”... “privilegiare metodi, rivolti alla soluzione
dei problemi, capaci di favorire l’acquisizione di competenze trasversali,
sia di tipo relazionale che di tipo cognitivo”.
Queste diciture sono state di volta in volta definite “obiettivi
specifici di apprendimento”, “competenze conclusive”
e “criteri” dalle varie commissioni di studio, di saggi, per
il riordino dei cicli, per la definizione dei curricoli della scuola di
base e della secondaria. In effetti, ben poco le differenzia, certo più
la forma che la sostanza; ma già nel 1979 i Nuovi programmi
della Scuola media proponevano concetti analoghi come obiettivo disciplinare
del saper fare dell’area delle Scienze matematiche, chimiche fisiche
e naturali.
Occorre accordarsi su quale significato diamo a termini come obiettivi,
capacità, competenze o “saper fare”; ma soprattutto,
occorrerebbe concordare e rendere univoche, quindi perseguibili, misurabili
e infine certificabili, le competenze.
Verificare la competenza “sa osservare” è relativamente
facile; ben più difficile è verificare la competenza “sa
analizzare” di cui l’osservazione può essere considerata
parte integrante.
È evidente però che, tanto più complesso e articolato
è l’elenco delle competenze, tanto più difficile diventa
il percorso per il loro conseguimento, la loro misurazione in itinere
e soprattutto la certificazione al termine del percorso scolastico.
Non va dimenticato, inoltre, che una competenza è la mobilitazione
delle capacità del singolo in una serie di situazioni analoghe
e può assumere valenze diverse col variare del contesto, il che
ne rende difficile la certificazione.
La competenza “osservazione e descrizione”, che consiste nell’osservare
i fenomeni, cogliere analogie e differenze, regolarità, fluttuazioni,
andamento temporale, può essere costruita a partire dall’osservazione
del proprio astuccio, delle differenze della Settimana enigmistica.
Si acquisisce quando si è in grado di cogliere variabili e relative
variazioni nel panorama visibile dalla finestra della propria aula, tra
due campioni di roccia, tra due foglie o tra due preparati microscopici.
La competenza “correlazione”, che consiste nel saper esprimere
relazioni, collegare cause ed effetti accompagna il curricolo di scienze
in ogni momento e nell’analisi di ogni evento e di ogni fenomeno,
naturale o artificiale. Lo studio di molti fenomeni complessi perde del
tutto di significato, di valenza, con forti ricadute sulla motivazione
degli studenti se slegato dalle cause che li determinano e soprattutto
dalle conseguenze che questi fenomeni a loro volta innescano. Lo studio
della Tettonica delle placche, slegato dagli eventi e dagli strumenti
che ne hanno permesso l’elaborazione e separato dalle conseguenze
che la dinamica globale ha non solo sulla sismicità o sulle orogenesi,
ma anche sulla stabilità dei versanti e quindi sull’antropizzazione
del territorio e sull’uso dei suoli si riduce ad una sterile elencazione
di dati e di fenomeni.
Quali strumenti
Ogni percorso, ogni argomento sviluppato dalle discipline scientifiche
può essere strumento ed occasione per l’acquisizione di competenze.
Progetti e percorsi di più ampio respiro, ma anche singoli esperimenti
o attività quotidiane sono momenti in cui si usano capacità,
si apprendono conoscenze: la mobilitazione integrata di questi due fattori
crea competenza.
Lo studente che, osservando due campioni di roccia, ne riconosce analogie
e differenze, individua quali di queste possono avere importanza per lo
studio ed il riconoscimento - presenza di cristalli, di fossili, di strati,
ecc.: può, con l’ausilio di manuali, insegnante, esperti,
ecc., essere in grado di classificarli, di individuarne l’origine
e se richiesto, di riconoscerli.
Le competenze utili per realizzare questo percorso - capacità di
osservazione, di riconoscimento di variabili, di classificazione, ecc.
- devono essere individuate chiaramente fin dall’inizio, implementate
e valorizzate, mediante esercitazioni, creazione di mappe concettuali
ben organizzate, di griglie di lettura, di fogli di appoggio ed infine
misurate al termine del singolo tratto del percorso.
Inevitabilmente, di volta in volta, il numero di competenze messe in gioco
è elevato; vengono coinvolte anche competenze trasversali e comuni
a tutte le discipline, come “la comunicazione e la documentazione”.
Ai fini della valorizzazione, della misurazione ed infine della certificazione
delle singole competenze, è indispensabile individuare di volta
in volta quali momenti all’interno del percorso curricolare possono
risultare più efficaci alla costruzione della singola competenza
e con quali strumenti.
Ogni competenza sarà attivata utilizzandola, e sarà misurata
più volte durante il percorso scolastico in situazioni definite
e controllabili.
Il curricolo disciplinare di tutta l’area scientifica diventa quindi
un mosaico in cui ogni tratto concorre alla costruzione di una o più
competenze che dovranno avere il loro riconoscimento anche in occasione
della valutazione, formativa o sommativa, in itinere o conclusiva.
La certificazione delle competenze
La certificazione diventa a questo punto un passaggio inevitabile anche
se complesso, all’interno del percorso disciplinare di tutta l’area
scientifica, come già è stato fatto in altri ambiti disciplinari.
Probabilmente più “spendibili” dovranno essere formalizzati
i parametri di competenza e le procedure di verifica della padronanza,
condizioni preliminari per l’accesso alla certificazione.
Le competenze dovranno essere comuni, univoche e condivisibili, sia per
quantità che per formulazione, oltre che individuabili e misurabili
mediante strumenti di facile applicazione.
In tal modo sarà forse possibile ottenere certificazioni di enti
esterni qualificati, appartenenti all’università o al mondo
del lavoro, che incentivino la preparazione raggiunta e promuovano la
cultura scientifica.

Progetto Orientamento per i geometri
ISITCGP di Châtillon
L’Istituzione scolastica di Istruzione tecnica, commerciale, per
geometri e professionale di Châtillon sta realizzando da alcuni
anni un percorso didattico che si rivolge alle classi prime del corso
geometri e che è stato chiamato “Progetto orientamento -
approccio alla professione del geometra”.
Scopo di questo progetto è inserire nel curricolo di una classe
prima alcuni moduli disciplinari, che propongano problematiche tipiche
del lavoro del geometra, anticipando alcuni argomenti che normalmente
vengono affrontati solo nel triennio di indirizzo e facendo intravedere,
già all’inizio del proprio percorso di studi, alcuni aspetti
della futura professione.
Era necessario utilizzare le capacità e le conoscenze già
in loro possesso per favorire la formazione di un abito mentale conforme
alle competenze professionali dell’indirizzo, ma, coerentemente
con le indicazioni del POF dell’Istituzione scolastica, facendo
riferimento ove possibile a problemi concreti che richiedano per il loro
sviluppo la partecipazione attiva degli allievi.
Per far ciò, era necessario predisporre un progetto che avesse
requisiti di pluridisciplinarità e di organicità, che producesse
risultati credibili e comunque didatticamente, qualitativamente significativi,
evitando di vestire di credibilità progetti troppo banali, come
progettare case da costruire poi con i mattoni del LEGO, utilizzando le
limitate competenze in possesso di una classe che è ancora dell’obbligo
scolastico.
La scelta è caduta sulla realizzazione di un progetto che combina
aspetti legati alla conoscenza ed alla gestione del territorio, in parte
già di loro patrimonio, a quelli della cartografia, del diritto,
della Pianificazione Territoriale ed Urbanistica.
Il progetto
Il progetto consiste nella costruzione di alcune cartografie tematiche,
realizzate utilizzando come base la Carta tecnica regionale scala 1:5.000;
lo scopo è quello di comprendere ed identificare quanti e quali
elementi, componenti ambientali, naturali o indotti, stabili o in evoluzione,
vadano osservati, studiati e cartografati, al fine di avere una sufficiente
e puntuale conoscenza del territorio che ci circonda e sul quale il geometra
effettuerà la sua progettazione. Finalità fortemente educativa,
che stravolge la logica tradizionale secondo la quale il primo compito
del geometra è quello di progettare, realizzare, conservare e migliorare
opere civili. Diventa invece prioritaria, se non altro in ordine di tempo,
la conoscenza delle caratteristiche dell’ambiente nel quale la progettazione
viene fatta.
Il percorso
La prima fase, conoscitiva, è rappresentata da alcune uscite sul
territorio e dalla accurata visione delle foto aeree con l’uso di
stereoscopi; particolarmente interessante è risultato il confronto
fra foto aeree di anni diversi, volo ’83, volo ’91 che ha
permesso un’analisi dell’evoluzione dell’uso del territorio.
A questa fase è seguita la produzione delle cartografie, individuate
tra quelle che la classe, dopo ampio dibattito, ha ritenuto utile produrre;
sono state quindi prodotte le diverse cartografie tematiche, in piccoli
gruppi e in almeno due versioni per poter effettuare i necessari riscontri,
su lucidi dotati di riferimenti cartografici, di adeguata legenda e dei
loro cartigli. È stata un punto di arrivo, ma anche punto di partenza
per il successivo lavoro di integrazione degli elaborati.
La fase di analisi e di integrazione
dei dati
Mediante semplice sovrapposizione dei trasparenti è stato possibile
evidenziare anche la sovrapposizione delle varie componenti, ambientali,
naturali, come le pendenze, i corsi d’acqua e le zone umide e le
relative “Fasce di rispetto”, le aree boscate, gli affioramenti
rocciosi e, con più difficoltà, le aree soggette a rischi
naturali, come frane o esondazioni, o artificiali e antropiche, quindi
carte dell’uso del suolo, della viabilità, dei servizi, tutte
costituenti in qualche modo dei vincoli o comunque dei condizionamenti
per l’uso e per la Pianificazione del territorio.
L’uso del trasparente è preparatorio al lavoro che verrà
realizzato negli anni seguenti, con l’uso di un Software finalizzato,
già in possesso dell’Istituzione.
Sulla base dei dati acquisiti, è stato realizzato un confronto
con la Carta del Piano Regolatore Generale Comunale, previa analisi della
simbologia normalmente utilizzata e introduzione ai concetti di zonizzazione
e di regolamentazione dell’uso delle varie zone del Piano.
L’attività si è conclusa con alcuni approfondimenti,
ad esempio la definizione di un “regolamento” e degli strumenti
di promozione per i siti di “interesse naturalistico o architettonico”
della zona, quali: realizzazione di sentieri attrezzati, pulizia di aree
dismesse, valorizzazione di aspetti paesaggistici, educazione all’uso
del territorio.
Il lavoro ha richiesto la collaborazione, e qualche compresenza, tra gli
insegnanti di Scienze, di Estimo ed Economia Rurale, di Costruzioni, e
l’introduzione di nozioni di Diritto e di Cartografia; a questo
si è aggiunta la collaborazione e la disponibilità degli
Uffici Tecnici Comunali di Châtillon e di Saint-Vincent, sia per
la fornitura di materiale cartografico che con la partecipazione di tecnici
ed amministratori agli incontri, duranti i quali sono stati illustrati
i Piani regolatori dei Comuni interessati.
Valutazione
Il progetto ha richiesto agli alunni l’elaborazione di conoscenze
già in loro possesso, acquisite principalmente nel corso di geografia
e scienze; in tale disciplina da alcuni anni è in atto una sperimentazione,
con ridistribuzione e razionalizzazione dei contenuti che consente, già
alla fine della classe prima, di acquisire una visione di insieme sia
della Scienza della Terra che della Scienza della Natura. Inoltre nuove
conoscenze sono state introdotte dagli insegnanti delle materie tecniche
del triennio che, con modalità diverse, hanno dato la loro disponibilità.
Il progetto ha permesso contemporaneamente una prima valutazione di insieme
delle competenze mobilitate da uno studente di prima superiore: capacità
di osservazione e di analisi sistematica delle variabili e delle caratteristiche
di un ambiente, di classificazione delle variabili e soprattutto di individuazione
delle categorie da classificare, di confronto ed infine, di sintesi, competenze
difficilmente riconoscibili, e quindi certificabili in lavori a corto
respiro.
Le classi via via coinvolte hanno dimostrato sempre ottima partecipazione,
interesse vivace agli argomenti proposti, con produzione di elaborati
complessivamente di qualità. Tra le motivazioni, non va escluso
il fatto che il corso geometri, come altri indirizzi dell’istruzione
tecnica, presenta un percorso organico, ma molto articolato, spesso frammentato,
che sostanzialmente non permette agli studenti di acquisire una visione
complessiva delle problematiche professionali se non alla fine del quinquennio.
È evidente, invece, come la possibilità di intravedere le
finalità dei propri sforzi può avere significative ricadute
sulla motivazione degli studenti, aspetto certamente non secondario, in
particolare in un istituto tecnico.
Ma la scelta del percorso proposto nasconde un’ulteriore motivazione:
l’idea, personale, che alla figura professionale del geometra, per
la quale stanno emergendo problemi di occupabilità potrebbero essere
coerentemente ed efficacemente attribuite competenze sulle problematiche
ambientali, in particolare il monitoraggio, la gestione e la pianificazione
del territorio, esigenze di grande attualità ed urgenza.
La scuola nel suo complesso dovrebbe interrogarsi e affrontare questo
problema, che si sta manifestando come un diffuso disagio e che richiederà,
come per tutti gli indirizzi tecnici, un’analisi attenta e mirata
di tutto il settore.
Susanna Occhipinti
Geologo, insegnante di Scienze della Terra e Scienze
della Natura presso l’ISITCGP di Châtillon.
Si è occupata nell’a.s. 2000/2001, con semi distacco presso
il Servizio Ispettivo, del Curricolo 3-18 e di competenze per le discipline
scientifiche; nell’anno 2001/2002 con semi distacco, è incaricata
di organizzare un Centro risorse per la Didattica delle Scienze.
